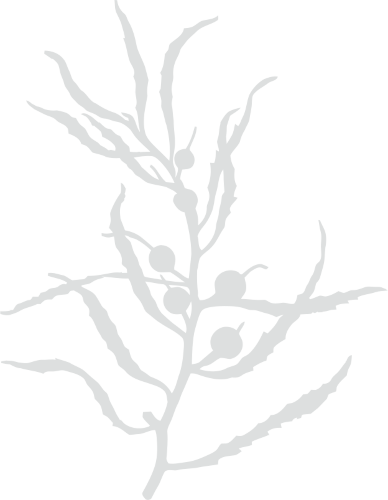God bless Miss Black America
Watch over Miss Black America
She cried tears of success
We wish her long happiness
Miss Black America
Sisters, we’re all so very proud
Of that natural look we see among the crowd
Worldwide admiration
From nation to nation
They love you, Miss Black America
We love you, too, Miss Black America
You’re such wonderful people
And so beautifully equal
Miss Black America
Curtis Mayfield, Miss Black America
Nel 1970 Curtis Mayfield incide un disco che segnerà profondamente la storia della musica afroamericana. Lo intitola semplicemente con il proprio nome: Curtis. Tra i brani in scaletta c’è anche Miss Black America, un affascinante gioco di specchi tra l’esaltazione della bellezza nera e una metafora del percorso che gli Stati Uniti dovranno ancora compiere per mettersi alle spalle secoli di razzismo e ingiustizie. Sappiamo bene che i cambiamenti si riveleranno più lenti e controversi del previsto, tuttavia ha senso partire proprio da questa canzone per provare a raccontare un’altra storia.
Le pagine che seguono, in effetti, si reggono su alcuni presupposti fondamentali: il primo, forse il più importante, è che sono state scritte da un bianco. Questo significa che la prospettiva è inevitabilmente diversa rispetto a un afrodiscendente, a partire dal fatto che non si sono vissuti sulla propria pelle episodi di violenza fisica, verbale o psicologica a causa del colore. Tutto ciò, in un modo o nell’altro, influisce nell’osservare gli interrogativi che attraversano la cultura afroamericana contemporanea, sottoposta – forse mai come in questi giorni – a stimoli apparentemente agli antipodi. D’altronde un’indagine su come musica e società interagiscano all’interno dell’America nera vuol dire anche (o soprattutto) tracciare le coordinate attraverso cui il risultato di questa sinergia si proietta all’esterno. Ovvero in direzione di un pubblico in larga parte bianco, di estrazione borghese e che magari non si è mai allontanato troppo dal posto in cui è nato. Vederlo come un limite sarebbe però come ridurre la portata del patrimonio culturale africano all’interno del triangolo atlantico, ai cui vertici ci sono anche Europa e America. Un mondo che si è espanso aggrovigliandosi attorno al pensiero occidentale, ma che nel nuovo millennio ha dovuto fare i conti ancora una volta con la potenza dell’identità diasporica.
Ecco, il secondo presupposto dei prossimi capitoli è che ci sarà molto spazio per discorsi come quello che avete appena letto. Nel senso che ogni capoverso è pensato per sostenere una conoscenza in divenire,che evita di dare per scontato qualunque aspetto, spingendo anche chi è già addentro alla questione a rimettere in gioco le proprie sicurezze. Non c’è niente di più bello che scoprire nuovi punti interrogativi, ancora meglio se si può fare prendendo delle storie e provando a incastrare l’inizio di una con il finale di un’altra. Per questo motivo l’idea di tracciare dei percorsi sonori è molto distante dal mostrare l’evoluzione di un linguaggio musicale: al contrario, qui partiamo dall’assunto che per osservare da una nuova angolazione la cultura afroamericana bisogna polverizzare l’idea che abbiamo di soul, rap, jazz, blues e via dicendo. La nebulosa che si viene a creare attraverso tale processo ha dei confini assai meno netti, a prescindere dalla constatazione che tutti questi generi, ovviamente, continuano a esistere nel panorama musicale odierno e ad avere delle caratteristiche ben definite. Allo stesso tempo, però, confluiscono – attraverso determinati artisti e, in special modo, determinati dischi – in una dimensione che ha il nome di “contemporary r&b”, sospesa al di fuori del tempo e dello spazio. A essa appartengono le periferie di Atlanta e i paesaggi subsahariani, la fascinazione per il misticismo egizio e quello per il frusciare di un vecchio vinile; ma anche i tentativi di (ri)appropriazione culturale di film e cartoni animati, l’incessante dialogo con il mito del black capitalism e la possibilità di unire i figli della diaspora attraverso il vocabolario afrofuturista.
In realtà la definizione di contemporary r&b esiste da molto tempo, eppure soltanto adesso pare così propensa a inglobare stimoli che rimbalzano tra industria discografica e cinematografica, cibandosi di algoritmi e nidificando su piattaforme di audio e video in streaming. Il fatto stesso che la presenza dell’acronimo r&b, cioè rhythm’n’blues, tenga ancorato il passato alla contemporaneità è un esempio perfetto di come si muove la musica afroamericana. In questo senso, peraltro, torna attuale il discorso sulla hauntology che Mark Fisher e Simon Reynolds facevano qualche anno fa prendendo spunto dagli scritti del filosofo Jacques Derrida, quando parlava di una resistenza delle idee marxiste dopo la morte del comunismo. Nel nostro caso allargheremo ancora un po’ il concetto, tentando di fotografare lo spettro del blues prebellico tra i sogni e gli incubi dell’universo in cui viviamo: un piano temporale all’interno del quale un ventenne scomparso in Mississippi negli anni Trenta, come Robert Johnson, ha insospettabili connessioni con un coetaneo o una coetanea nati a cavallo tra i due secoli dalle parti di New York, Londra o Kingston. Li accomuna non soltanto l’essere neri, o i versi che hanno registrato appoggiando le labbra a un microfono, ma l’intero ventaglio di possibilità che questo comporta in termini storici, sociologici e culturali.
Arriviamo così al terzo, e ultimo, presupposto: sarebbe semplicistico parlare di Stati Uniti senza individuarne i fili che li legano alla Giamaica e all’Inghilterra del secondo Novecento. Inutile dire che è solo una delle strade percorribili, anche se nel rimettere mano alle origini dell’hip hop, all’importanza dei block parties nel Bronx e all’emergere del rap come principale colonna sonora della comunità afroamericana, non si possono escludere dalla visuale né i sound system caraibici né il rilievo assunto dall’identità Black British nel panorama musicale internazionale. Basta pensare alla scena che oggi gravita attorno a nomi quali Alpha Mist, Sampha o Jorja Smith. Per tale motivo seguire certi indizi potrebbe condurre a smarrirsi in posti geograficamente lontanissimi, tra campionamenti che accostano i grandi classici a rarissime stampe private; brani le cui liriche cercano di coniugare un approccio conscious a un’epica di autoesaltazione, rischiando continuamente di essere etichettati come “black music” solo in base all’etnia di chi li ha composti. Allo stesso tempo ci si può imbattere in un’intera colonna sonora – quella di Black Panther: Wakanda Forever – che prova a ricomporre la diaspora a partire da un’Africa fantascientifica, spingendosi al di là di qualsiasi certezza avremmo accampato anche solo dieci anni fa.
Tutto questo ha reso parzialmente inutilizzabili i paradigmi che si usavano abitualmente per interpretare la musica afroamericana e il suo impatto sociale, dal momento che i tentativi di stabilire generi e categorie come si faceva prima sembrano ormai del tutto arbitrari. O meglio, appaiono come delle sovrimposizioni che condannano una materia viva e pulsante all’interno di geometrie più banali e prevedibili di quelle in cui è mutata. Certo, è importante sottolineare ancora una volta che le sue varie declinazioni non hanno cessato di esistere. Per intenderci: il blues in quanto blues c’è ancora, ma il peso che aveva sul mercato discografico e in senso socio-culturale è slittato, piaccia o meno, in quella bolla multiforme che abbiamo genericamente indicato come contemporary r&b. E questo vale anche in ottica brutalmente commerciale, in particolar modo quando parliamo di nuove generazioni, sia nere che bianche.
Ma se il riverbero del blues nella cronologia della musica afroamericana è stato smembrato, con il rap che ne ha ereditato le tematiche lasciando che le ossessioni ritmiche venissero sublimate nel funk e da lì nella techno di Detroit, un caso a parte è quello del jazz. In questo momento, di fatto, è impossibile non accorgersi come un certo tipo di jazz abbia dichiaratamente iniziato a rivolgersi a un pubblico che di norma è lontano da quegli ascolti. Nel caso di Shabaka Hutchings, Thundercat, Nubya Garcia, Kamasi Washington o Lakecia Benjamin, siamo davanti a musicisti che hanno intercettato quel mutamento di cui prima e hanno tentato di darne un’interpretazione personale. Ciò non significa che la loro proposta si discosti sempre dalla tradizione o che sia più interessante di chi continua a muoversi nel territorio del jazz propriamente detto; tuttavia chi li segue è mediamente più giovane e onnivoro rispetto ai cultori di Charles Mingus e Archie Shepp (pur recuperando, ad esempio, il Davis più sincopato e il Coltrane più spirituale). Sempre che queste due platee non si mescolino tra loro, eventualità che fortunatamente accade più spesso di quanto sembri.
A proposito, a costo di togliere un po’ di poesia, aggiungiamo anche un altro elemento: collettivi come i The Comet Is Coming o i Sons Of Kemet – due tra i progetti più fortunati del già citato Shabaka Hutchings – hanno anche un diverso posizionamento sui cartelloni dei grandi festival e degli eventi dal vivo rispetto alla scena jazz più “canonica” nonché, se vogliamo, una tendenza più spiccata a ibridarsi e assumere ulteriori espressioni. Non è affatto un dettaglio, anche dal punto di vista della promozione e del marketing. Per intenderci, siamo nei giorni in cui uno come André 3000 può permettersi di pubblicare una tracklist completamente strumentale basata sul suono dei flauti, gettandosi alle spalle il mito degli Outkast e intitolando un brano I swear, I Really Wanted To Make A “Rap” Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time. Interessante, no?
A ogni modo, se dovessimo scegliere alcune parole per descrivere che influenza hanno i suoni dell’America nera contemporanea sul resto del pianeta, non potrebbero certamente mancarne due: riscatto e consapevolezza. Riportare in primo piano il concetto di blackness e black pride stimola il cervello a ragionare, a sviluppare un pensiero critico che si espande insieme ai pugni chiusi di Black Lives Matter. Tutto questo è evidente quando si osserva come le proteste contro la discriminazione razziale abbiano trovato spunti e sollecitazioni anche nella lotta per la parità di genere, un argomento da sempre particolarmente dibattuto all’interno della comunità afroamericana, insieme all’ipersessualizzazione e all’omofobia. Sarebbe ingenuo però non tenere in conto, all’interno di questo scenario, la posizione assunta dall’industria discografica nel suo intercettare, ancora una volta, ciò che il pubblico desidera e trovare il modo migliore per venderglielo. In un momento in cui ai flirt con le inclinazioni gangsta e bling-bling degli anni Novanta si antepone la coscienza civile di un artista come Kendrick Lamar, interpretare l’onestà intellettuale di chi vive ai piani alti è, paradossalmente, ancora più difficile. Ecco per quale motivo anche le parole capitalismo, lotta di classe e industria discografica torneranno spesso nei nostri discorsi, sia quando seguiremo la parabola di un gigante come Gil Scott-Heron, che quando sarà la cosiddetta Windrush Generation a finire sotto i riflettori.
È curioso come molte delle suggestioni che ritroverete nelle prossime pagine, dagli splendori alieni di Sun Ra ai sospiri percussivi dei Last Poets, passando per la tragedia del Middle Passage e della doppia coscienza teorizzata da W.E.B. Du Bois, continuino ad attraversare l’identità afroamericana del nuovo millennio aggiungendo altri significati a quelli che già avevano in precedenza. È l’ennesima prova del perché antico e moderno non entrino mai davvero in conflitto se l’uno non esclude l’altro, finendo anzi per disegnare incredibili ipotesi di futuro. Un po’ come accadeva nel 1996 lungo i quarantacinque minuti di The Last Angel Of History, il documentario sperimentale in cui John Akomfrah ha maneggiato la macchina da presa per travasare l’estetica nera in una sorta di panafricanismo totale. Nella musica questo mescolarsi di linee temporali è particolarmente evidente, ad esempio, con i bagliori gospel confluiti sui dischi Stax o Motown degli anni Sessanta e nel modo in cui questi ultimi hanno poi influenzato tanto il nu soul di Erykah Badu, quanto il retro soul di Sharon Jones o il contemporary r&b di Beyoncé e Janelle Monáe. Ma potremmo limitarci a riflettere su tutti i samples rimasticati dai campionatori negli anni Ottanta e Novanta, scoprendo che porzioni di quegli stessi album sono finiti su produzioni rap, dance e trip hop.
Ci sarebbero infiniti sentieri che si possono percorrere: il tentativo di stimolare quella conoscenza in divenire che dicevamo all’inizio, non a caso, vale soprattutto nel bisogno di immaginare certi processi senza l’ossessione di arrivare sempre a dei punti fermi. Le possibilità combinatorie sono infinite, quelle che vi appariranno di qui a breve ne rappresentano una sezione microscopica. Il resto tocca a voi. Così, quando ci chiediamo il peso che ha avuto il reggae per le ragazze e i ragazzi che hanno popolato le sottoculture inglesi, viene naturale pensare al ruolo delle sperimentazioni dub nella jungle e nella grime. Una domanda genera l’altra. Se Kool Herc non avesse avuto origini giamaicane, l’hip hop sarebbe identico a come lo conosciamo? E se Wattstax avesse avuto più risonanza di Woodstock? E se Marvin Gaye non fosse mai riuscito ad avere il via libera per registrare What’s Going On? Ma anche: è davvero Virgil Abloh ad aver consacrato una volta per tutte la centralità della musica afroamericana nel campo dell’alta moda, condividendo la strada con i vari Kanye West, Tyler The Creator e June Ambrose? E infine, cosa succede se il suono dell’America nera finisce sotto l’enorme teca museale dell’America bianca?
Alcune di queste domande, a guardare bene, non hanno bisogno di una risposta. Tutto sommato il gioco dei what if – o della storia controfattuale, se preferite – è molto meno divertente quando si pretendono delle sicurezze. Meglio lasciare i punti interrogativi in bella vista, fantasticando su tutto ciò che rimane.