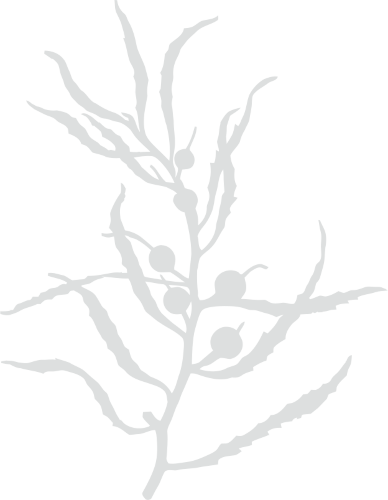Nei giorni in cui l’Italia si sveglia con il cuore spezzato per l’ennesima vittima di una violenza che dovremmo smettere di chiamare cieca perché, al contrario, ci vede benissimo, Il Giornale sceglie di riproporre una storia ai suoi lettori, quella di Milena Quaglini, in un articolo così titolato: “Punisco i maschi”: e Milena divenne la vedova nera dell’Oltrepò.
Al di là della già fuorviante doppia dichiarazione riassunta in parole che non rispettano affatto la verità di una vicenda che sempre molto male è stata raccontata da una certa stampa – Milena non puniva, Milena non era una “vedova nera” (ma su questo torneremo) –, il tempismo della pubblicazione sappiamo bene non essere casuale. Sappiamo voler invitare chi legge alla riflessione più prossima: anche le donne uccidono gli uomini. A suo modo, lo stesso articolista lo ammette: Le serial killer donne non sono molte, per questo motivo risaltano spesso più degli uomini. E quindi? Cos’è che vuole realmente dirci la riproposta di un caso di cronaca di vent’anni fa nelle stesse ore in cui si scopre l’inferno a cui sono stati condannati Giulia Tramontano e il suo bambino? Nelle stesse ore in cui anche Pierpaola Romano viene condannata a morte da un uomo che non accetta che lei possa lasciarlo?
Persino a un lettore poco attento appare chiaro il maldestro tentativo di salvaguardare uno status quo che vede, in Italia, morire una donna ogni tre giorni per mano di qualcuno di molto vicino a lei. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 28 maggio 2023, ma è tristemente facile aggiornarli come segue: soltanto da gennaio a oggi, sono 49 le donne uccise nel nostro Paese. 41 sono vittime di femminicidio, 24 coloro che sono state ammazzate dal partner o dall’ex partner. Si tratta, in media, di otto assassinii al mese.
Perché, dunque, Il Giornale sente forte la necessità di scomodare una vecchia, comunque triste, storia come quella di Milena Quaglini e di farlo con un titolo che di Milena e della sua storia, in realtà, non racconta proprio nulla? Perché persino La Stampa scrive che bisogna insegnare alle ragazze a salvarsi? Perché per una volta, una soltanto, non possiamo guardare in faccia il problema e affrontarlo? Perché è importante che chi subisce debba sempre, in qualche modo, mutarsi in soggetto agente?
Ogni volta che un uomo ammazza una donna, si fa un gran parlare di ciò che lei avrebbe dovuto o potuto fare. Riconoscere i segnali, si dice. Ma quali? Non presentarsi all’incontro chiarificatore, pure. Ma che significa? Significa che persone adulte, che magari si sono volute bene, non possono rivedersi, non possono parlare? Prendiamo ad esempio proprio il caso di Giulia che tanto clamore ha suscitato.
Sappiamo, da ricostruzioni e testimonianze, che la giovane e il suo assassino, Alessandro Impagnatiello, avevano una relazione. Sappiamo che lei aveva scoperto che lui intratteneva, anche, un altro rapporto fuori dalla coppia e che per questo Giulia aveva pensato dapprima di lasciarlo e poi di provare a trovare una qualche forma di compromesso. Che lei potesse scegliere di perdonarlo o meno, che la storia fosse o meno giunta al capolinea, che lui potesse essere un narcisista – come in questi giorni si affrettano a scrivere i giornali – non rende e non avrebbero reso più semplice prevedere l’epilogo che tutti conosciamo.
Quanti hanno vissuto o vivono vite e relazioni parallele? Quanti hanno vissuto e vivono il tradimento? Quanti hanno vissuto e vivono il perdono? Sono tutti assassini? Sono tutti vittime? Sono tutti colpevoli? Davvero stiamo cercando una qualche forma di colpevolizzazione più o meno esplicita di Giulia e del bambino che portava in grembo? È una narrazione pericolosa, così sottile da rischiare di passare inosservata, eppure capace di attecchire più di quanto possa apparentemente sembrare. Cos’è che si sta cercando di dire, che bisogna scappare per non morire? Non sempre la violenza si esercita con l’utilizzo della forza fisica. Non sempre è uno schiaffo o un’offesa, seppur pesante, a lanciare quei famosi segnali. A volte è niente, a volte è un attimo, a volte è così intrinseco l’abuso da apparire naturale, impercettibile.
Non serve andare troppo a fondo per scoprire che le storie di femminicidio si somigliano tutte. Si somigliano perché, spesso, nascono dalla volontà dell’abusata di lasciare l’abusante che, a sua volta, non può tollerare l’affronto. È questione di proprietà e di onore, di vita e di morte. Di morte, soprattutto. O con me o con nessun altro. E, allora, quali segnali ognuna delle troppe donne sacrificate ogni anno avrebbe dovuto cogliere? Cosa avrebbero dovuto fare, restare?
Non sempre ci sono gli estremi per una denuncia. E quando ci sono, spesso, sembrano non bastare. D’altronde, lo scrivevamo già qualche anno fa, in Italia le vittime di femminicidio muoiono due volte: quando si fanno coraggio e si affidano allo Stato e quando se ne vanno davvero. I casi di donne che hanno denunciato a vuoto – anche a più riprese – i loro futuri assassini sono tantissimi. Talmente tanti che, spesso, finiscono con l’inibire chi subisce violenza a rivolgersi alle autorità per non sentirsi ancora più sola e impotente, destinata a una morte che sembra inevitabile, la punizione per aver amato la persona sbagliata. E, invece, amare non è mai uno sbaglio.
L’errore, piuttosto, è quello di uno Stato incapace di ascoltare e proteggere, di garantire la giusta tutela a ogni sua componente, a chi a esso si affida – o dovrebbe affidarsi – per evitare di finire in prima pagina, immortalato per sempre in un sorriso inconsapevole di essere l’ultimo. Come quello di chi resta anche a telecamere spente, quando la notizia non fa più rumore, ma il vuoto della perdita miete altre vittime.
Così è accaduto anche a Pierpaola Romano, la poliziotta che è stata ammazzata a Roma da un suo collega. Un episodio che avrebbe meritato qualche attenzione in più e che, invece, si è volutamente derubricato come minore rispetto alla violenza subita da Giulia Tramontano perché – stante alla narrazione di cui sopra – giustificare un doppio femminicidio nel giro di così poco tempo può causare corto circuito. Come si ribatte, infatti, che anche le donne uccidono gli uomini? Dove la trova Il Giornale un’altra storia a supporto? E cosa si inventa Galimberti nel suo tentativo di trovare una spiegazione che addirittura incolpi la madre di un assassino? Le sue dichiarazioni, in tv, le abbiamo sentite tutti ma, anche qui, non abbiamo storto troppo il naso.
Quando come Mar dei Sargassi abbiamo scelto di dar voce a Milena Quaglini – attraverso le parole di Elisa Giobbi –, lo abbiamo fatto perché di quella donna che aveva subito per una vita intera abbiamo avvertito tutto il dolore, il peso, la frustrazione, persino il dubbio. Quello che la riguarda è, infatti, uno dei casi di cronaca più noti in Italia. Una vicenda più unica che rara, nel panorama giudiziario nostrano – ma non solo –, che vede una donna vestire i panni dell’omicida, scomodando il termine desueto di androcidio, l’uccisione di un uomo nel caso in oggetto non in quanto tale, ma in quanto maschio prepotente e torturatore. Proprio come quelli che finiscono con l’essere ammazzati dalla Quaglini che prima di arrivare a commettere violenza la vede, la sente, la prova sulla pelle di sua madre, quando è il padre a esercitarla, e poi sua, quando in personaggi abusanti si imbatte a ripetizione. Tra questi c’è persino suo marito.
Gli omicidi attribuibili a Milena mi sono sembrati ascrivibili a una forma estrema, anche se inconsapevole, di ribellione a un patriarcato cieco e violento. E raccontare la sua storia significa portare alla luce una verità scomoda che in qualche modo non smette di riguardare tutti quanti, scrive Elisa Giobbi nelle sue considerazioni finali. E, forse, senza cercare giustificazioni o spalleggiamenti, senza prestare il fianco a chi potrebbe vedere in queste frasi delle motivazioni valide ai violenti crimini commessi, ha ragione.
Milena è stata una ribelle. Ha fatto male, ma facendosi sempre male per prima. Ha condannato, condannandosi. Eppure, nemmeno questo, nemmeno la sua brutalità è bastata a restituirle una qualche dignità di donna. Sessualizzata nella ricostruzione della sua personalità disturbata, nei dettagli pruriginosi del suo aspetto, persino nel suo dolore. Angelo sterminatore: hanno sempre scritto i giornali. Ma Milena non è stata un angelo e, in qualche modo, nemmeno una sterminatrice. Non ha ucciso per il gusto di farlo, ha ucciso perché non ne poteva più di subire. Per questo la strumentalizzazione che ne fanno ancora oggi le destre, taluna stampa e quei gruppi di rivendicazione maschile che fanno del suo caso un esempio in risposta ai tanti, troppi femminicidi che ogni giorno riempiono le pagine dei quotidiani italiani, le farebbe male.
Perché non basta una donna che uccide un uomo a livellare le cose, a smontare la realtà dei fatti di una società costruita a uso e consumo patriarcale. Non basta a giustificare la violenza sistemica che – sempre a rigor di vocabolario – il sesso forte esercita sul sesso debole. È un errore, è mera speculazione, è riportare Milena in vita per abusarne di nuovo. E abusarne di nuovo è, anche, ripubblicare la sua storia mentre scorrono, ovunque, le immagini di Giulia e del suo meraviglioso pancione.