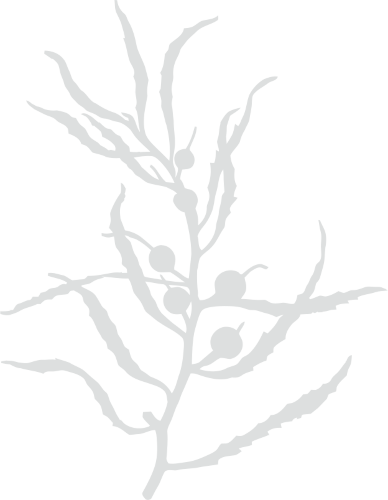Il giorno in cui terminai i miei studi liceali lo vissi come un’enorme liberazione. Ero uno dei tanti adolescenti che – a tredici anni – individua il percorso sbagliato e fatica, poi, ad ammetterlo innanzitutto a se stesso, trascinando la propria insofferenza per l’intero quinquennio delle superiori. Il confronto con materie, sì, affini alla mia indole matematica, lontane – però – dalla curiosità che mi attraeva verso altre discipline, era stato piuttosto pesante da reggere. Così, quell’estate, finalmente scelsi. Scelsi Roma e la facoltà di Comunicazione de La Sapienza e, per la prima volta in vita mia, sbarcai nella capitale.
Il primo giorno di corsi si divideva tra le aule della sede in via Salaria e il complesso dell’ex Caserma Sani, ai lati opposti del centro città. Non avevo idea di dove fossero né l’una né l’altra. Ai tempi Google Maps non tracciava ancora l’itinerario verso qualunque delle nostre destinazioni e domandare agli estranei era l’unica maniera di scoprire le strade e gli angoli di ogni nuova città.
Dopo un’ora di Informatica, le lezioni continuavano nel cuore del quartiere Esquilino: Aula Magna, Antropologia Culturale, prof. Massimo Canevacci.
Ricordo fui subito attratto dai suoi insegnamenti, da quella passione che gli brillava negli occhi quando raccontava gli studi di una vita trascorsa tra le culture native del Brasile, Xavante e Bororo. Canevacci illustrava i processi evolutivi di quei popoli partendo dai rituali iniziatici che li caratterizzavano, fino alle sfide digitali che consentivano loro di adoperare una comunicazione moderna ed efficace e, quindi, esistere e resistere.
Forse già quel pomeriggio, o al più quello successivo, ci affidò la filosofia a cui legava la propria esistenza, un concetto tanto semplice e tanto potente a cui sembrava impossibile porre resistenza: stupore è l’attimo prima. Ci parlò di un fiore della foresta amazzonica, il camalote, un giglio d’acqua che porta con sé lungo le rive dei fiumi le proprie radici durante gli spostamenti. Un fiore nomade, vagabondo, from roots to routes, dalle radici alle strade: prendere, fare bagaglio e lasciarsi andare al movimento. La sintesi perfetta della vita delle popolazioni Xavante e Bororo era anche la sfida a cui chiamava le grandi metropoli digitali.
Tenni il mio primo esame universitario proprio con il professor Canevacci, domandandogli – non appena entrò in aula – che fosse lui stesso a interrogarmi, anziché uno degli assistenti. Desideravo ardentemente confrontarmi con lui, dialogare di quei sistemi e apprendere ancora qualcosa, fino all’ultimo istante.
La verifica delle mie competenze terminò con un 30 con lode di cui ancora conservo lo statino gelosamente e la sensazione di aver trascorso poco meno di una mezz’ora in compagnia di un vecchio amico a confrontarci sul senso di tante piccole, grandi cose.
Da quel giorno, non ho mai smesso di pensare alle lezioni del prof. Canevacci e a quel fiore sudamericano, tanto da decidere di dedicargli la collana di saggistica della casa editrice, denominata, appunto, Camalote.
Ed eccoci qui, a queste ore di grande emozione: ieri, il 14 marzo, Mar dei Sargassi ha pubblicato il racconto di viaggio di Massimo Canevacci, i suoi studi di una vita, i suoi mutamenti, con le radici ricche delle proprie origini e lo stupore vagabondo a conquistare bellezza in giro per il mondo. Proprio come in Aula Magna alla Sani, come quel novembre agli esami, l’incontro e il confronto con Canevacci si sintetizza in un processo di riflessione e creatività che riesce a muovermi, a infondermi gioia e ispirarmi passione e coraggio.
Sono immensamente grato al professor Canevacci, anzi, a Massimo, di avermi concesso – quindici anni dopo quelle lezioni – questo che considero uno dei piccoli personali traguardi di cui, un giorno, guardando indietro, mi sentirò profondamente orgoglioso e felice.
A voi che leggerete, invidio l’attimo prima. Quello dello stupore che, sono certo, si trasformerà in meraviglia.
Leggi Stupore indigeno: clicca qui.