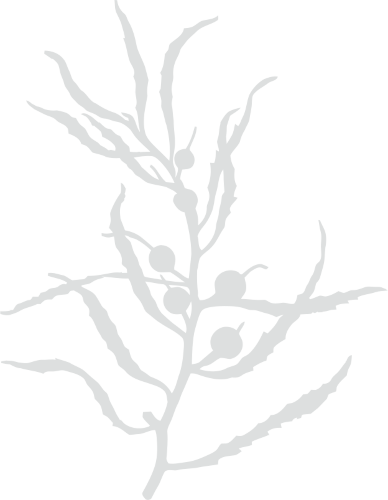Sin dall’alba dei tempi, i poeti nomadi hanno narrato storie sulla devastazione provocata dalla jilal, la stagione più temuta. Niente mostrava il potere del deserto rosso più della jilal, con la sua calura che non conosce tregua né pietà. Sotto il suo influsso, tutto il nostro mondo inaridiva. Vedevamo ovunque scene di morte e distruzione, sterpaglie spezzate e ossa secche disseminate a terra, alberi assetati di pioggia che, rimasti in piedi, si stagliavano come scheletri. Quando gli animali non avevano più acqua ed erba a sufficienza, il loro latte si prosciugava e morivano, soccombendo alla malattia. Perfino gli enormi, resilienti e amati cammelli capitolavano davanti alla jilal. La stagione secca poteva spazzare via intere famiglie e i loro animali nel giro di qualche settimana. – Shugri Said Sahl, L’ultima nomade
C’è sempre la jilal nei ricordi di infanzia di un somalo. C’è il tempo della sete, della carenza d’acqua, dell’erranza nel deserto per poter esaudire il desiderio di assaporare nuova vita. Ci pare irreale, persino anacronistico, eppure ancora oggi la Somalia è una delle zone più colpite dalla siccità. Nessuno sembra accorgersene, ma proprio in queste settimane, nel Corno d’Africa, sedici milioni di persone stanno affrontando la quinta stagione delle piogge che fallisce. Muoiono gli animali, la terra si inaridisce, muoiono uomini, donne e bambini. Giovani e anziani, passato, presente e futuro. Muoiono di sete. Muoiono di fame. Muoiono perché il mondo immaginato da John Lennon è ancora, e resterà, il motivetto di qualche pacifista.
Soltanto negli ultimi mesi, un milione di persone, in Somalia, è stato costretto a lasciare le zone rurali. Tantissime sono quelle ancora in viaggio. Camminano per giorni, a volte per intere settimane, camminano per avvicinarsi alla città, lì dove improvvisano gli accampamenti, si riuniscono, costruiscono campi di legno e terra, tende arrangiate. Erano pastori e hanno perso tutto. Erano pastori e adesso non sono più. Hanno fame e paura. Chi arriva a destinazione è malato, a volte sopravvive ai propri figli, altre li condanna a morte. Le donne, denutrite, non producono latte. Senza latte, i più piccoli non arrivano all’indomani. Persino uno stupido raffreddore può rivelarsi fatale.
Ogni sera, all’interno dei campi si improvvisano collette per le famiglie che non hanno di che mangiare. Riso. Riso bianco. Riso per tutti. Qualcosa da mettere nello stomaco. Solo nei pressi di Baidoa, 600mila persone si sono accampate sperando di sopravvivere. Non sanno, o lo scoprono tardi, di essere intrappolate: al-Shabaab ha assediato la città. Al-Shabaab è tornata a far paura.
Per spostarsi da Mogadiscio a Baidoa, si prende un aereo. Le strade, non più percorribili, raccolgono carcasse di animali, resti di violenze e corpi inermi. Gli attentati si susseguono in tutto il Paese, dalla capitale a Buloburde, da giugno ad appena due giorni fa. Hotel assaltati, rapimenti, minacce, è difficile per le persone scappare. È ancora più difficile, per gli operatori sanitari e umanitari, compiere il proprio destino: aiutare i somali a sopravvivere.
Contro l’organizzazione terroristica di matrice islamica che, da anni, terrorizza la popolazione, la Repubblica Federale di Somalia sta intensificando i suoi sforzi per convincere la comunità internazionale a revocare l’embargo sulle armi. Imposta per la prima volta nel 1992, da praticamente tre decenni il Paese soffre la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nata con lo scoppio della guerra civile e confermata nel novembre del 2022. L’embargo ha lo scopo di prevenire la proliferazione di armi illegali e di materiale correlato nel Paese, vietando la vendita, il trasferimento o la fornitura di strumenti e attrezzature militari alla Somalia, tranne in alcuni casi espressamente autorizzati.
Ufficialmente, è per contrastare i ribelli che il 16 maggio scorso Joe Biden ha firmato l’ordine per schierare, secondo il New York Times, fino a 450 militari statunitensi dopo il ritiro voluto da Donald Trump nel 2017. La Somalia, insomma, non può difendersi da sola, ma va difesa. Ovviamente, con altre bombe e tutte di democrazia esportata. Non solo stelle e strisce, però. Anche il tricolore sventola ancora nell’ex colonia. Non se ne parla. Forse per la vergogna o, forse, perché è meglio non ricordare quanto gli italiani sappiano essere brava gente. La Somalia, per noi, è l’omicidio – mai chiarito – di Ilaria Alpi, ma dimentichiamo che è anche il Paese della Folgore, degli stupri, delle torture fotografate eppure rinnegate. La responsabilità di ciò che è oggi porta la firma di molti, la nostra su tutte.
La cellula terroristica rappresenta uno dei principali problemi del Paese e rischia, ora che la situazione alimentare, economica e sociale si sta facendo insostenibile, di ingigantire la propria influenza sul territorio. L’ONU riferisce che negli ultimi mesi, nonostante – o proprio per – la siccità, al-Shabaab ha avvelenato un pozzo nella regione dell’Hiran. L’offensiva, però, non si ferma qui. A ottobre, un attentato nel cuore di Mogadiscio è costato la vita a centoventuno persone e ne ha ferite altre trecento.
La sete come arma. La fame come minaccia. La guerra è anche, e soprattutto, questo: annientare le persone, consumarle, ridurle a corpi senza vita. Madri costrette a vedere i propri figli morire. A scegliere chi e quanti portarne dietro nella lunga transumanza. Non tutti possono partire: la lotta alla sopravvivenza è, principalmente, la lotta a chi sta meglio, la cernita di chi è chiamato alla lotteria della vita e chi, invece, è destinato a restare da solo, ad attendere che la fiamma si spenga nonostante, talvolta, i propri anni non contino nemmeno tutte le dita di una mano.
Quando possono, nei punti di distribuzione realizzati dalle organizzazioni non governative – le ONG che tanto ci fanno paura – donne e bambini riempiono le taniche di acqua. Venti litri è il massimo che possono trasportare, è quanto deve bastare per fare tutto: bere, lavarsi, lavare i vestiti, eliminare i bisogni. Tutto. Le infrastrutture idriche, in Somalia, sono quasi inesistenti, le risorse delle organizzazioni limitate. Portare aiuti significa rischiare la vita. E con le strade presidiate, sotto assedio, chiuse, trasportare umanità è sempre più complesso. La siccità corre veloce. Più veloce di qualsiasi buona intenzione.
Per ogni campo, c’è al massimo un bagno. Uno per due, trecento, quattrocento persone. La crisi climatica si mischia alla crisi alimentare. Secondo le Nazioni Unite, quasi otto milioni di persone, circa metà della popolazione somala, sono già stati colpiti da una siccità senza precedenti e, di questi, 213mila sono ormai ridotti alla fame. Muoiono i somali, muoiono in tanti, e quando i morti diventano troppi si finisce con il parlare di carestia. È una condizione rara – scrive Save The Childen – ma quando si verifica significa che c’è un’estrema carenza di ciboe che bambini e adulti in un’area definita stentano a sopravvivere. L’ultima volta che se ne è parlato, in Somalia, era il 2011. Nel Sud del Paese quasi 490mila persone stavano vivendo livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta. Circa 260mila persone sono morte, oltre la metà erano bambini di età inferiore ai 5 anni.
Sono i più piccoli, infatti, i più suscettibili a malattie e disturbi come dissenteria, diarrea, colera, malaria e polmonite. Le conseguenze di questa situazione possono portare alla morte oppure, se il bimbo sopravvive, causare un arresto della crescita ostacolando lo sviluppo mentale e fisico. A volte, per porre rimedio, le famiglie privano i bambini del diritto allo studio, li affidano ad altri, si combinano matrimoni in cambio di un tozzo di pane.
Per verificare lo stato di salute di un bambino basta osservarne la circonferenza del braccio, gli occhi chiusi, il collo che fatica a stare su. Sono i segni della malnutrizione grave. Sono i segni del fallimento umano. Tra aprile e giugno 2023 – avvertono le organizzazioni umanitarie – la carestia è prevista tra le popolazioni agropastorali nei distretti di Baidoa e Burhakaba, tra le popolazioni sfollate nella città di Baidoa, nella regione di Bay e a Mogadiscio. Ma a rischio è l’intera Somalia.
A Dadaab, in Kenya, l’UNHCR (l’Agenzia ONU per i Rifugiati) sta fornendo alle famiglie appena arrivate assistenza in denaro, acqua potabile e strutture igieniche, oltre a servizi mirati per i più vulnerabili, come i bambini malnutriti. Ma le risorse non bastano. La siccità ha avuto un impatto anche sugli oltre 230mila rifugiati e richiedenti asilo che già vivono nella serie di campi che costituiscono la città, oltre che sulle comunità ospitanti circostanti. Il sovraffollamento e la mancanza di strutture igieniche sufficienti hanno contribuito a un’epidemia di colera, con quasi cinquecento casi identificati dalla fine di ottobre, molti dei quali bambini.
«Per più di un anno abbiamo avvertito della catastrofe che si stava preparando in Somalia. Quella a cui assistiamo è una delle peggiori crisi che abbiamo mai visto. Ma dove sono gli aiuti?» si chiede Binyam Gebru, vicedirettore nazionale di Save the Children in Somalia. Ci sono quattro interventi chiave per evitare la carestia: allarme e azione tempestivi, risposta coordinata a livello internazionale, accesso umanitario completo e privo di barriere, cessazione dei conflitti. Interventi necessari per garantire cibo, acqua e supporto al bestiame nell’immediato, ma insufficienti se non accompagnati da politiche a lungo termine che pongano l’attenzione sui fattori alla base della fame, della malnutrizione, dell’insicurezza alimentare. Dei conflitti e dei cambiamenti climatici.
Tuttavia ce n’è una, di azione, che dobbiamo e possiamo fare anche noi e subito: ascoltare la Somalia. Impedire che finisca nel dimenticatoio, che la fame diventi normale, che lo siano le guerre e la siccità, che un bambino – che potremmo salvare con pochissimi centesimi – muoia perché non ha diritto alla vita. Impedire che una madre debba scegliere tra i suoi figli, vederli consumarsi tra le sue braccia, che debba dannarsi per sempre. Ascoltare la Somalia e farle da megafono, portare la sua storia nelle nostre. Perché è stata la nostra, con la S maiuscola, a riscrivere e condannare la gente somala e ancora non abbiamo chiesto scusa.
Alla fine della jilal, la lunga stagione secca, quando finalmente le nuvole tuonavano cariche di pioggia, volgevamo gli occhi al cielo con rinnovata speranza. Mentre il deserto placava la sua sete, la terra rossa crepitava nuovamente di vita. Il senso di responsabilità si alleggeriva; gli adulti accoglievano l’acqua con tamburi, canti e danze. I bambini ingrassavano e si rimettevano in salute. Di sera, seduti attorno al fuoco, assorbivano fiabe e poesie tramandate di generazione in generazione.